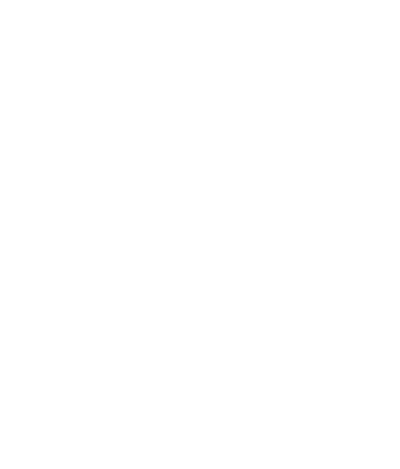Caso Sardegna: dal 5% al 74,52% di raccolta differenziata
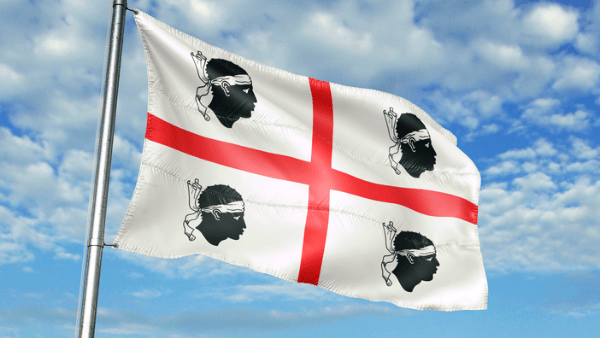
Dopo aver raggiunto il vertice della classifica nazionale per riduzione dei rifiuti e raccolta della differenziata, la Regione Sardegna adotta un meccanismo tariffario per incentivare la diffusione della tariffazione puntuale. A cura di Igor Staglianò Nel 2004 la Sardegna era la penultima Regione in Italia con il 5% di raccolta differenziata, nel 2020 secondo ISPRA […]
Parte da Torino accordo McDonald’s e Iren per abbattere la quantità di rifiuti

Il progetto, che durerà un anno, sarà calato nei ristoranti McDonald’s presenti nelle province di Torino (13), Reggio Emilia (4), Parma (4), Piacenza (3), La Spezia (3) e Vercelli (1) Un patto tra McDonald’s e Iren Ambiente per lanciare un progetto pilota che parte da Torino sul fronte della sostenibilita’ ambientale coinvolgimento 28 ristoranti tra […]
Rifiuti, Legambiente: 30 milioni persi dal Comune di Palermo

«Oltre 5 mesi per preparare e presentare progetti già in parte definiti da tempo dagli uffici della Rap e ritrovarsi nell’ultimo giorno della scadenza dell’avviso (tra l’altro prorogato di altri 30 giorni) di fronte a un problema tecnico insuperabile. Non è solo sciatteria, è incompetenza e dolo, l’ennesima beffa ai danni della città e dei […]
Ottima iniziativa per la raccolta di giocattoli presso l’ecocentro di Albairate

Quanti giocattoli sono finiti tra le nostre mani o quelle dei nostri figli? Un numero difficile da quantificare in maniera oggettiva ma che ci porta alla mente molti ricordi. Mi sorge però spontanea un’altra domanda: dove sono finiti tutti quei giocattoli? Spesso ci si ostina a voler conservare tutto perché lo si lega ad una […]
Ripristinata la raccolta differenziata per i positivi al Covid

Vittoria della campagna di Eco dalle Città sul ripristino della raccolta differenziata dei rifiuti nelle case dei cittadini positivi al Covid. Giovedì 3 marzo l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato una nota tecnica in cui, dopo aver spiegato le ultime evidenze scientifiche sulla diffusione del Sars Cov-2, descrive le modalità operative per la gestione dei […]
Raccolta dell’organico obbligatoria. Ecco cosa cambia per i Comuni

Dal primo gennaio 2022 è scattato l’obbligo della raccolta differenziata dell’organico per tutti i Comuni d’Italia. Ma a che punto siamo sul territorio nazionale? Tra l’aumento di prodotti compostabili, uno sguardo a norme e buone pratiche che potrebbero fare la differenza In Italia la raccolta differenziata dell’organico è a buon punto. L’organico rappresenta il 43% […]
Covid, dopo due anni continua il paradossale tabù sui rifiuti

Continua la brutta pagina, tutta e solo italiana, che vede una indicazione ufficiale di NON fare la raccolta differenziata nelle case dei positivi al Covid, mandando a incenerimento tutto quanto. Cautelativamente ipotizziamo che circa 300 mila tonnellate di rifiuti avrebbero potuto essere differenziate e sono finite invece negli inceneritori. A parte le valutazioni ambientali, in termini economici significa […]
Anci-CONAI, aumentati i corrispettivi per la raccolta
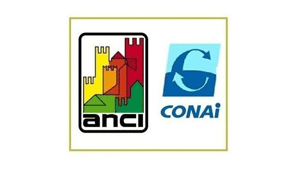
La decisione del comitato di verifica congiunto dice che il coefficiente di revisione dei corrispettivi è il 2,27% Il Comitato di Verifica ANCI-CONAI ha formalizzato la revisione annuale dei corrispettivi riconosciuti per la raccolta e il conferimento ai Consorzi di filiera dei rifiuti di imballaggio. In particolare, i corrispettivi hanno avuto un incremento che tiene conto dell’indice NIC 2020/2019, che […]
Scarti e rifiuti tessili, con il nuovo anno obbligatoria in tutta Italia la raccolta differenziata

L’obbligo di raccogliere separatamente i rifiuti tessili, in Italia, scatterà a partire dal 1 gennaio 2022, come previsto dal decreto legislativo n.116/2020, mentre a livello europeo, la raccolta differenziata di questa tipologia di rifiuto diventerà obbligatoria entro il 2025. L’obiettivo è quello di diminuire l’impatto ambientale del tessile ed incentivare il riutilizzo e il riciclo. Secondo le stime […]
Dal 1 gennaio, diventa obbligatoria la raccolta dell’umido in tutti i Comuni italiani

partire dal 1° gennaio 2022 in tutti i Comuni italiani diventa obbligatoria la raccolta differenziata dell’umido: gli scarti organici dovranno essere separati dagli altri rifiuti. Lo prevede l’articolo 182 ter del decreto legislativo 152/2006 che recepisce in Italia la direttiva europea 2018/851 in materia di rifiuti. L’entrata in vigore di questo obbligo anticipa di due anni un […]