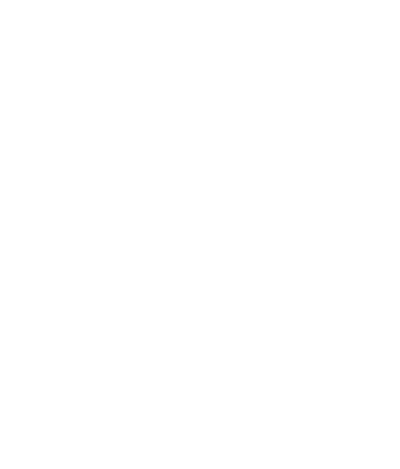Europa: la marcia inarrestabile dei sistemi cauzionali per bevande

Natural Mineral Waters Europe (NMWE), UNESDA Soft Drinks Europe e Zero Waste Europe : È ora di riconoscere il ruolo dei sistemi di deposito cauzionale (DRS) nel raggiungimento di un’economia circolare per gli imballaggi per bevande monouso nell’Unione europea E’ stato diffuso oggi il comunicato congiunto (segue in formato integrale) in cui Natural Mineral Waters […]
Nuovo piano rifiuti Emilia-Romagna, al via il percorso partecipato: obiettivo 80% di raccolta differenziata

La gestione dei rifiuti urbani e speciali, gli impianti per il trattamento, la tariffa puntuale, l’economia circolare come leva fondamentale per contribuire alla neutralità carbonica entro il 2050 e la bonifica dei siti contaminati. Sono i temi al centro dei cinque focus del percorso partecipativo lanciato dalla Regione Emilia-Romagna in vista della redazione del nuovo Piano regionale dei rifiuti che per la prima volta riguarderà […]
Bevande, nuove regole di riciclo: torna il vuoto a rendere

Il decreto Semplificazioni reintroduce i criteri per diffondere il sistema di resi per bottiglie, fiaschi e lattine di vetro, alluminio, plastica Allo studio la cauzione per gli imballaggi riutilizzabili, con maggiore attenzione per quelli di plastica, vetro e metallo usati per le bevande. Il decreto Semplificazioni convertito in legge a fine luglio è ancora molto generico e […]
Corte dei Conti: “Raccolta differenziata genera benefici economici, ma non al Sud”

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato, con delibera n. 14/2021, la relazione “Prime analisi sulla qualità della spesa dei Comuni” nella quale riferisce i risultati di una specifica analisi sulla gestione di alcuni rilevanti servizi comunali, quali le funzioni di amministrazione, gestione e controllo, polizia locale e rifiuti, che assorbono il 45% della […]
ARO Bari 2: i Comuni contro il progetto di un nuovo inceneritore

L’ARO BA 2 è l’organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporti dei rifiuti da parte delle aggregazioni dei comuni di Modugno (capofila), Sannicandro di Bari, Bitetto, Binetto, Bitritto, Giovinazzo e Palo del Colle.Nei comuni coinvolti nell’AroBa2 è previsto un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta con l’applicazione della “tariffazione puntuale”, sviluppato […]
Cattolica: più RD, meno TARIP

Cattolica è uno dei principali centri turistici della costiera Romagnola. Nota anche come la “Regina dell’Adriatico” ospita ogni anno un numero impressionante di turisti: nel 2018 oltre 1.800.000 secondo Confartigianato locale. Numeri impressionanti se si paragonano ai 16.800 residenti. Ma Cattolica non è solo turismo e turisti: da qualche tempo è anche eccellenza nella raccolta […]
GreenPeace: indicazioni per il recepimento della direttiva SUP in Italia

Le scelte a cui sarà chiamato il nostro governo nelle prossime settimane impatteranno profondamente sulla capacità del Paese di accelerare la transizione verso un modello economico circolare che favorisca la riduzione del consumo di risorse naturali e della pressione esercitata dalle attività umane sugli ecosistemi. Cambiare il paradigma della crescita economica è fondamentale per ricondurre […]
I rifiuti di Roma a Napoli?

Era Venerdì 9 aprile quando sui maggiori quotidiani nazionali ha iniziato a rimbalzare una notizia che aveva dell’ìincredibile: la Città di Roma chiedeva una disponibilità ad aziende Campane per il conferimento di rifiuti indifferenziati. “La Sapna, società provinciale per la gestione dei rifiuti della Città metropolitana di Napoli, ha ricevuto una richiesta da parte della […]
Quanto si “differenzia” in Italia?

In un’ottica di transizione verso un’economia circolare, la raccolta differenziata svolge un ruolo importante. In Italia viene differenziato il 61 per cento dei rifiuti urbani e ne viene riciclato il 51,3 per cento (sopra la media UE). La differenziazione è però più elevata al Nord e Centro Italia. Su queste differenze regionali influiscono principalmente il […]
Il record di Troina

Con una percentuale del 78% registrata nel mese di marzo, mai sfiorata fino ad ora, la raccolta differenziata nel Comune di Troina (EN) raggiunge un nuovo record. A renderlo noto, il sindaco Fabio Venezia: “Grazie alle scelte lungimiranti compiute negli ultimi anni, oggi Troina è una cittadina pulita e decorosa con un sistema di gestione dei rifiuti molto […]