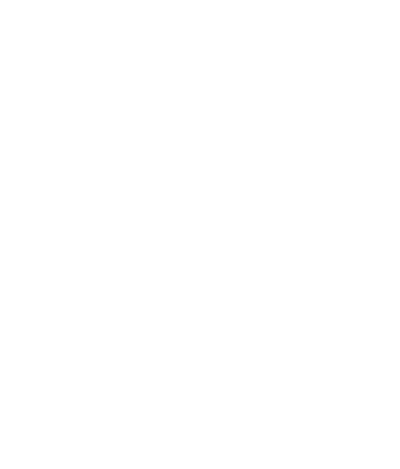Nuova proroga TARI e PEF rifiuti al 20 luglio 2024

Con un emendamento al cd. “decreto coesione” (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), approvato dalla Commissione Bilancio, il termine per l’approvazione dei PEF per il servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti TARI è stato nuovamente prorogato al 20 luglio 2024. Il termine originario, previsto dall’ articolo 3, co. 5-quinquies del dl 228/2021, fissato […]
Delibere Tari, arriva ok alla proroga dell’approvazione al 30 giugno 2024

La commissione Finanze del Senato ha approvato due emendamenti voluti dall’Anci: arriva quindi la proroga tanto attesa delle Delibere Tari al 30 giugno 2024 e la salvaguardia fino alla legge di conversione sul Superbonus. La Commissione Finanze del Senato ha infatti adottato due emendamenti su richiesta dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci), che avranno un impatto significativo sulle […]
Imballaggi delle bevande, in arrivo il deposito con cauzione: quali sono i vantaggi e perché l’Italia si oppone

Per rispettare i target Ue sul riciclo degli imballaggi, sempre più Paesi europei hanno scelto la strada dei depositi cauzionali. Ecco come funzionano C’è una novità inserita nel regolamento europeo sugli imballaggi, in via di approvazione, che tra qualche anno potrebbe diventare realtà anche in Italia. Si tratta del Sistema di deposito cauzionale – in inglese, Deposit […]
Nuovo tavolo di lavoro per impianti minimi

Il Senato approva una risoluzione che apre la strada alla creazione di un tavolo di lavoro focalizzato sugli ‘impianti minimi’ nel panorama della gestione dei rifiuti. La proposta, promossa dalla senatrice Silvia Fregolent di Italia Viva, riceve il via libera dalla commissione ambiente di Palazzo Madama, impegnando il governo a istituire questo tavolo di discussione. […]
Il lancio del progetto europeo “ERIC” consente alle autorità locali di prevenire la produzione di rifiuti di plastica. Tre comuni italiani aderiscono

È stato lanciato un nuovo progetto a livello europeo che mira a fornire alle città maggiori strumenti e conoscenze per prevenire l’aumento dei rifiuti di plastica. Elevating Reuse In Cities (ERIC) è un nuovo progetto, finanziato dal Plastics Solutions Fund, che mira a mettere i comuni europei in condizione di ridurre la produzione di rifiuti di plastica. Guidato da 10 […]
Riforma delle Tariffe Tari: al via l’indagine di ARERA

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha avviato un’importante indagine sui criteri di articolazione delle tariffe nel servizio di gestione dei rifiuti urbani. Questo processo fa seguito alla delibera n. 41/2024 del 6 febbraio 2024, che ha iniziato il percorso verso il riordino dei corrispettivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, […]
Indagine del Parlamento Europeo sui lobbisti del packaging

Il dipartimento di sicurezza del Parlamento europeo ha avviato un’indagine sul comportamento di alcuni lobbisti riguardo alle nuove norme europee sugli imballaggi sostenibili, secondo quanto riportato da fonti interne all’istituzione. L’eurodeputata Maria Angela Danzì ha sollecitato la Presidente del Parlamento, Roberta Metsola, affinché avviasse un’indagine interna per chiarire eventuali violazioni da parte dei rappresentanti di […]
Controversia ambientale nell’UE: Italia isolata sulla questiona imballaggi

Il 18 dicembre, i Ministri dell’Ambiente dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo su un nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Mentre la maggior parte degli Stati membri ha resistito agli sforzi per indebolire le misure ambientali, l’Italia è stata l’unico paese a votare contro l’accordo, ignorando, secondo l’Ufficio europeo per l’ambiente (EEB), […]
Riforma del settore rifiuti: 4 nuove delibere di ARERA

Arera ha recentemente pubblicato quattro delibere che riformano il settore rifiuti dando seguito alla recente sentenza n. 7196 del 24 luglio 2023 del CdS ed alle previsioni normative per il riordino dei servizi pubblici locali, per la tutela della concorrenza, per le operazioni “Salva mare” e per favorire l’economia circolare, tenendo conto del principio comunitario […]
Il TAR Sicilia conferma l’obbligo del posizionamento dei bidoni per la RD all’interno degli spazi condominiali

Secondo la recente sentenza del TAR Sicilia n. 1925 dello scorso 21 giugno 2023[1] risulta assolutamente legittima un’ordinanza comunale che imponga di utilizzare gli spazi comuni condominiali per il posizionamento dei bidoni carrellati destinati al conferimento delle principali tipologie di rifiuti. Non si configura infatti nessun pericolo di carattere igienico-sanitario per i residenti del condominio e gli […]