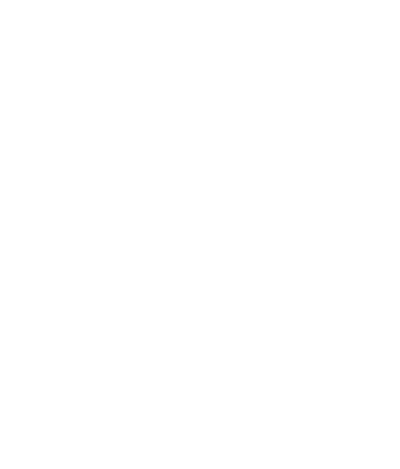Italia sotto procedura di infrazione dall’UE per il mancato rispetto della direttiva sui rifiuti

L’Unione Europea ha recentemente avviato una procedura di infrazione contro l’Italia per il mancato corretto recepimento della direttiva quadro sui rifiuti. La Commissione Europea ha inviato una lettera di costituzione in mora all’Italia, segnando il primo passo di questa procedura. La direttiva sui rifiuti dell’UE mira a prevenire e ridurre la produzione di rifiuti, migliorando […]
Procedura di infrazione UE contro l’Italia per la direttiva sulla plastica monouso

La Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia a causa del mancato recepimento completo e corretto della direttiva europea sulla plastica monouso. L’Italia, infatti, è stata ritenuta non conforme agli obblighi di trasparenza del mercato unico previsti dalle normative comunitarie. Bruxelles ha inviato una lettera di costituzione in mora all’Italia, segnando l’inizio […]
Nuove norme UE in fase di studio per ridurre sprechi tessili ed alimentari

Il Parlamento europeo ha recentemente adottato una serie di nuove normative volte a contrastare gli sprechi alimentari e a promuovere il riciclo dei rifiuti tessili entro il 2030. Queste misure, inserite nell’ambito dell’economia circolare, mirano a affrontare il problema della produzione e dello smaltimento eccessivo di rifiuti nell’Unione europea. L’UE genera ogni anno circa 60 […]
Rifiuti pericolosi e gestione europea

La gestione dei rifiuti pericolosi è una delle questioni più importanti per l’Unione Europea. Nonostante l’adozione di una serie di normative per garantire la protezione dell’ambiente e della salute pubblica, la gestione dei rifiuti pericolosi rimane una questione critica. Eurostat ha riferito che nel 2019 nell’UE sono stati prodotti oltre 100 milioni di tonnellate di […]
L’UE boccia (di nuovo) l’Italia su rifiuti e smog
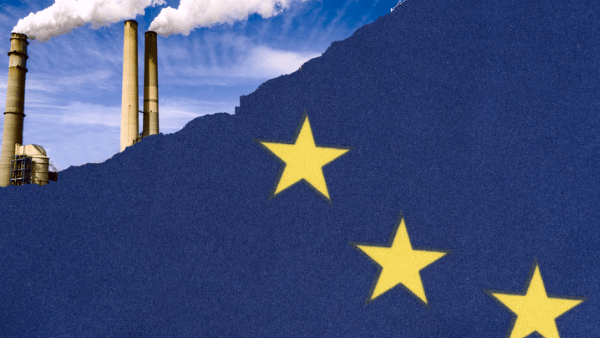
Presentata la valutazione dell’attuazione ambientale (EIR), il documento che valuta come l’Italia applica le norme UE: la Commissione ci boccia su rifiuti e smog, mentre ritiene incoraggianti i passi avanti del nostro Paese per l’economia circolare Norme ambientali europee, dove stiamo sbagliando?Nel documento di valutazione dell’attuazione delle norme ambientali europee il nostro Paese non presenta […]
Ue adotta rapporto su riduzione emissioni di metano: approvati emendamenti che cambiano la strategia sulle discariche

Martedì 28 settembre la Commissione ENVI del Parlamento Europeo (Ambiente, Sanità pubblica e Sicurezza alimentare) ha adottato la relazione sulla strategia Ue per ridurre le emissioni di metano, con obiettivi vincolanti per raggiungere i target climatici comunitari in linea con l’Accordo di Parigi. Il documento, che ha ricevuto 61 voti favorevoli, 10 contrari e 7 astensioni, chiede che la […]
Ue, nuova tassonomia verde: escluso l’incenerimento e rafforzati limiti del riciclo chimico

Incenerimento escluso e riciclo chimico soggetto a vincoli molto più restrittivi. Sono queste le principali novità sul trattamento dei rifiuti contenute nell’atto delegato relativo agli aspetti climatici della nuova tassonomia verde Ue, la classificazione delle attività economiche che possono essere definite “sostenibili“ all’interno dell’Unione Europea. Viene quindi confermato quanto anticipato alcune settimane fa dal portale endswasteandbioenergy. L’atto delegato, adottato dalla Commissione Ue […]
Pacchetto economia circolare, in Gazzetta Ufficiale anche la direttiva sulle discariche

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche il provvedimento sulle discariche, l’ultimo dei quattro D. Lgs per il recepimento delle direttive Ue del “pacchetto economia circolare” che contiene i decreti relativi anche a veicoli fuori uso, Raee e imballaggi. Il 14 settembre è stato infatti pubblicato il D.Lgs 3 settembre 2020 n. 121 “Attuazione della direttiva Ue […]
La gestione dei rifiuti organici, un potenziale non sfruttato nell’Unione Europea

La Bio-based Industries Consortium (BIC), la principale associazione industriale europea che pone la circolarità, l’innovazione e la sostenibilità al centro della bioeconomia europea, in collaborazione con Zero Waste Europe (ZWE) ha chiesto alla Scuola Agraria del parco di Monza di produrre un rapporto unico nel suo genere, che identifichiil potenziale non sfruttato per la valorizzazione dei rifiuti organici (rifiuti di giardino e alimentari) in Europa. […]
Tradotte le linee guida UE su rifiuti e Covid19

Pubblichiamo la versione italiana delle linee guida pubblicate lo scorso 14 aprile dalla UE sulla gestione dei rifiuti in tempo di Corona Virus Scarica la versione italiana