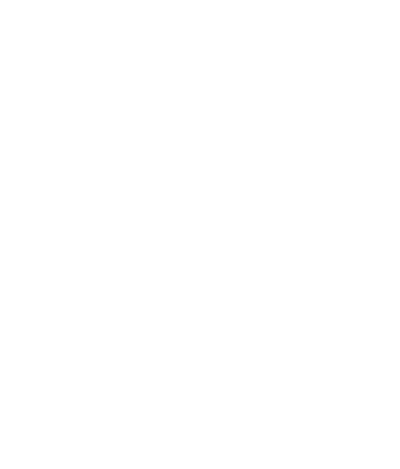Austria e DRS: per i produttori austriaci importanti novità

L’Austria si trova al centro di importanti cambiamenti nel settore delle bevande, con l’introduzione di obiettivi nazionali di riuso e l’imminente arrivo di un sistema di deposito cauzionale obbligatorio. Questi sviluppi stanno spingendo i produttori a espandere l’offerta di bevande ricaricabili, sia in termini di varietà che di formati disponibili. Fin dal 2021, l’Austria ha […]
Cassonetti intelligenti: criticità simili tra Francia e Italia

Gli ultimi sviluppi nella gestione dei rifiuti in Francia dimostrano che le difficoltà legate all’implementazione dei “cassonetti intelligenti” non sono esclusive dell’Italia, ma in alcuni casi hanno determinato problemi simili a quelli riscontrati nel Bel Paese. Vari casi recenti evidenziano le difficoltà incontrate dalle comunità francesi nel passaggio a nuovi sistemi di raccolta dei rifiuti, […]
Regolamento imballaggi UE: la Commissione Ambiente approva la proposta

La Commissione Ambiente del Parlamento Europeo ha approvato con 56 voti a favore, 23 contrari e 5 astensioni, la proposta di Regolamento imballaggi (PPWR). Il documento stabilisce i requisiti per l’intero ciclo di vita degli imballaggi, dalle materie prime allo smaltimento finale. Il testo verrà esaminato dalla plenaria a novembre. Questi i punti salienti della proposta approvata: Regolamento imballaggi: incoraggiare […]
Imballaggi, l’Italia stroncata dalla Ue sul riciclo: “Non basta, crescita dei rifiuti troppo alta. Necessario promuovere il riuso”

La Commissione europea difende la proposta di regolamento sugli imballaggi. E risponde al parere negativo espresso dalla Camera dei deputati, a giugno 2023, sulla scia di quanto fatto anche dal Senato. “La proposta mira a rimanere materialmente e tecnologicamente neutrale e non intende sostituire le soluzioni tecnologiche esistenti con altre. Tuttavia, data la crescita continua, passata e prevista, dei rifiuti di imballaggio nell’Unione europea, […]
Nuova bozza End of Waste sui rifiuti da costruzione e demolizione

A seguito dei numerosissimi appelli degli operatori nel settore edile, il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato una nuova bozza riguardante il decreto end of waste su rifiuti da costruzione e demolizione. Al suo interno sono presenti molte novità tra cui dei nuovi valori per la tabella dei limiti di concentrazione, meno restrittiva di quella presentata nel […]
Rifiuti pericolosi e gestione europea

La gestione dei rifiuti pericolosi è una delle questioni più importanti per l’Unione Europea. Nonostante l’adozione di una serie di normative per garantire la protezione dell’ambiente e della salute pubblica, la gestione dei rifiuti pericolosi rimane una questione critica. Eurostat ha riferito che nel 2019 nell’UE sono stati prodotti oltre 100 milioni di tonnellate di […]
Denuncia social per contrastare illeciti ambientali?

La denuncia social consiste nell’utilizzo dei social media e delle piattaforme online per denunciare pubblicamente comportamenti illegali o non etici. Questa pratica è diventata sempre più comune negli ultimi anni, in quanto i social media hanno reso più facile per le persone diffondere informazioni e mettere in luce le questioni sociali. Proprio pochi giorni fa, […]
Cambio di passo necessario sulle plastiche non da imballaggio secondo Eea

Dalla Commissione europea quest’anno si è vista una lotta sempre più mirata verso gli imballaggi in plastica, il che si dimostra un grande passo avanti, è però necessario portare all’attenzione un’altra enorme fetta di plastica della quale non si parla abbastanza, quella non per imballaggi. È stato da poco messo in risalto dall’Agenzia europea per […]
Plastica, Italia bene a metà. Ora tra bioplastica e riciclo il Paese è a un bivio

Per poco non arriviamo a quota 100. Non stiamo parlando di pensioni, ma di plastica. In Italia nel 2020 ne abbiamo consumati circa novantanove chilogrammi a persona. In totale sono quasi sei milioni di tonnellate, impiegate soprattutto per gli imballaggi (42 per cento del totale) e, con quote inferiori, per edilizia e settore automobilistico. «Il nostro Paese – […]
“Blocco della raccolta differenziata della carta scongiurato grazie all’export di macero”

Unirima, che raccoglie le imprese del macero, sottolinea le difficoltà del settore della raccolta e riciclo, frutto della crisi del gas che ha messo in difficoltà le cartiere. In primis, il crollo del prezzo della materia prima seconda. “In questa situazione di grande difficoltà, siamo riusciti ad adattarci e grazie alle esportazioni siamo riusciti a […]