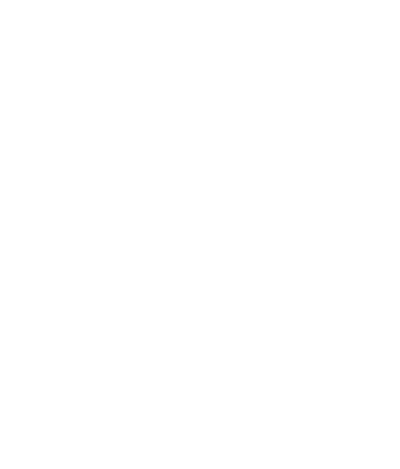Europa: la marcia inarrestabile dei sistemi cauzionali per bevande

Natural Mineral Waters Europe (NMWE), UNESDA Soft Drinks Europe e Zero Waste Europe : È ora di riconoscere il ruolo dei sistemi di deposito cauzionale (DRS) nel raggiungimento di un’economia circolare per gli imballaggi per bevande monouso nell’Unione europea E’ stato diffuso oggi il comunicato congiunto (segue in formato integrale) in cui Natural Mineral Waters […]
Alla scoperta dei Drs: cosa prevede il deposito cauzionale del decreto Semplificazioni

Gli imballaggi costituiscono una frazione minima dei rifiuti che generiamo ogni anno in Italia (il 7% nel 2020), ma rappresentano i protagonisti assoluti – assieme all’organico – della raccolta differenziata, conquistandosi il centro dell’attenzione pubblica e politica, che si interroga su come gestirli al meglio nella fase di post-consumo. Duole notare che a oltre vent’anni dall’introduzione […]
A Genova inaugurato il primo eco-compattatore per le lattine in alluminio

È stato presentato a Genova il nuovo ecocompattatore di Amiu, società deputata in città alla gestione dei rifiuti urbani. Il progetto, nato dalla collaborazione tra Amiu e l’assessorato all’Ambiente del Comune, è partito inizialmente con 12 ecocompattatori per le bottiglie e i flaconi in plastica. In questa nuova postazione nel centro storico si potranno conferire anche […]
Vuoto a rendere in Europa: il rapporto di ACR+

Nel mezzo di rinnovate discussioni su come raggiungere l’efficienza delle risorse e promuovere l’economia circolare in Europa, gli incentivi al vuoto a rendere ed al cauzionamento degli imballi sono ormai argomento fisso nelle discussioni intorno a potenziali strumenti per aiutare a raggiungere obiettivi ambiziosi di raccolta e riciclo e combattere il littering. ACR + ha esplorato le […]
Santeramo in Colle: “Abbiamo ampliato la sperimentazione ministeriale”

Santeramo in Colle: “Abbiamo ampliato la sperimentazione ministeriale” Mentre la sperimentazione nazionale sul vuoto a rendere si avvia verso un ineluttabile fallimento, c’è chi sul vuoto a rendere punta forte. È il Comune di Santeramo in Colle, in provincia di Bari. In occasione del passaggio alla raccolta porta a porta previsto nel capitolato per il […]
Per raggiungere gli obiettivi di raccolta e riciclo annunciati dall’industria delle bevande il deposito su cauzione è una strada obbligata

Anche le multinazionali guardano con interesse al vuoto a rendere Intervista a Silvia Ricci, Responsabile Campagne Associazione Comuni Virtuosi L’Associazione Comuni Virtuosi (ACV) da qualche anno si è espressa a favore dei sistemi di deposito su cauzione così come adottati all’estero… L’ACV si è espressa a favore del Deposito su cauzione per i contenitori di […]
Vuoto a rendere: una sperimentazione sbagliata non può fermare il processo

Stefano Ciafani, Presidente Nazionale di Legambiente: “Scarsa applicazione da parte del Ministero e boicottaggio da parte dei produttori di bevande. La sperimentazione fallirà, ma il vuoto a rendere va ripreso e ristabilito: è un tassello imprescindibile di un piano più generale per la riduzione dei rifiuti Di Attilio Tornavacca, direttore generale ESPER e Sergio Capelli, tecnico […]
Perché l’Italia rischia di perdere il vuoto a rendere

In Germania funziona da anni. Ora lo vara Londra. Ma da noi non decolla il compenso in denaro a chi restituisce lattine e bottiglie in alluminio, plastica e vetro. Perché la norma del 2017 scontenta tutti La speranza di un ritorno al passato per ora è vuota. Come i depositi di bottiglie di ristoranti ed esercenti. Perché […]