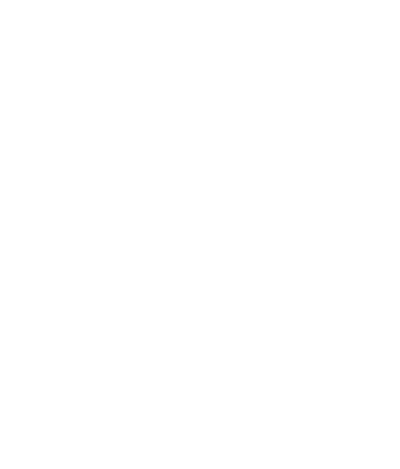Toti e Tata per il nuovo spot di sensibilizzazione ambientale dell’AroBa8

Lo spot “Che stai, a casa tua” di Toti e Tata, alias Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, ha recentemente fatto il suo ritorno per promuovere l’AroBa8, l’Ambito di Raccolta Ottimale della zona BA/8 in Puglia. Questo nuovo spot riprende lo spirito umoristico del duo comico, aggiornandolo con un messaggio di sensibilizzazione ambientale legato alla gestione […]
Emilia-Romagna: nuovi incentivi per i prodotti sfusi e meno rifiuti

L’Emilia-Romagna ha approvato un progetto di legge volto a incentivare la vendita di prodotti sfusi, con l’obiettivo di ridurre i rifiuti da imballaggio. Il provvedimento, proposto dalla capogruppo di Europa Verde, Silvia Zamboni, prevede fino a 5mila euro di incentivi per l’apertura di nuovi negozi di prodotti sfusi e per l’allestimento di “green corner” nei […]
Riforma delle Tariffe Tari: al via l’indagine di ARERA

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha avviato un’importante indagine sui criteri di articolazione delle tariffe nel servizio di gestione dei rifiuti urbani. Questo processo fa seguito alla delibera n. 41/2024 del 6 febbraio 2024, che ha iniziato il percorso verso il riordino dei corrispettivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, […]
Divieto europeo di export dei rifiuti plastici verso le economie emergenti

In una decisione che rivela un impegno tangibile per fronteggiare la crisi ambientale connessa alla plastica, l’Unione Europea ha ufficialmente varato un divieto totale sulle esportazioni di rifiuti di plastica verso le nazioni economicamente meno sviluppate. Questa determinazione, frutto di un accordo tra il Parlamento Europeo e i vari governi degli stati membri, sottolinea l’unità […]
L’UE boccia (di nuovo) l’Italia su rifiuti e smog
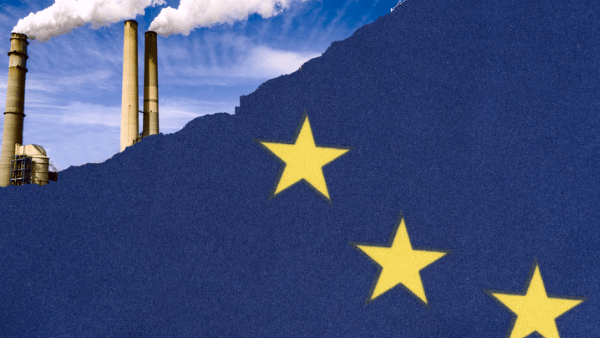
Presentata la valutazione dell’attuazione ambientale (EIR), il documento che valuta come l’Italia applica le norme UE: la Commissione ci boccia su rifiuti e smog, mentre ritiene incoraggianti i passi avanti del nostro Paese per l’economia circolare Norme ambientali europee, dove stiamo sbagliando?Nel documento di valutazione dell’attuazione delle norme ambientali europee il nostro Paese non presenta […]
Comm. Ecomafie, approvata in aula a Montecitorio relazione ‘Emergenza epidemiologica COVID-19 e ciclo dei rifiuti’

La Camera dei Deputati ha approvato oggi la relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (Commissione Ecomafie) “Emergenza epidemiologica COVID-19 e ciclo dei rifiuti” La Camera dei Deputati ha approvato oggi la relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al […]
Pacchetto economia circolare, pubblicato il decreto rifiuti e imballaggi

Recepite due delle direttive che andranno a modificare il Testo Unico Ambientale per quanto riguarda la definizione di rifiuto urbano, di rifiuti speciali assimilabili, di tracciabilità e responsabilità estesa È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il prossimo 26 settembre il decreto legislativo 116/20 che recepisce due delle direttive approvate due anni fa dall’Unione europea in materia […]
Costa: per aumentare la differenziata servono nuovi impianti

Il problema è l’impiantistica. Lo dice, in una intervista al Quotidiano Nazionale, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa (nella foto), a proposito della differenziata, sottolineando le responsabilità di comuni e regioni. “I player della gestione dei rifiuti sul territorio italiano sono le Regioni e i Comuni – ricorda Costa.- I Comuni hanno la competenza della raccolta, le Regioni hanno […]
ISPRA 2018: calano i rifiuti, solo 4 regioni rispettano i target EU

Si attesta a 29,6 milioni di tonnellate la produzione di rifiuti urbani, segnando una riduzione dell’1,7% rispetto al 2016. Dopo l’aumento riscontrato tra il 2015 e il 2016, sul quale aveva peraltro anche influito il cambiamento della metodologia di calcolo (inclusione nella quota degli RU dei rifiuti inerti derivanti da piccoli interventi di manutenzione delle abitazioni), si […]
La Regione Piemonte presenta le linee guida per la tariffazione puntuale

“Se vogliamo migliorare il sistema complessivo dei rifiuti piemontesi dobbiamo puntare sulla raccolta differenziata e sulla tariffa puntuale.” Sono state queste le parole dell’Assessore all’Ambiente della Regione Piemonte Alberto Valmaggia all’EcoForum per l’economia Circolare del Piemonte organizzato da Legambiente. Le parole dell’Assessore arrivano a seguito della presentazione dei dati sulla gestione rifiuti in Regione: Appena […]