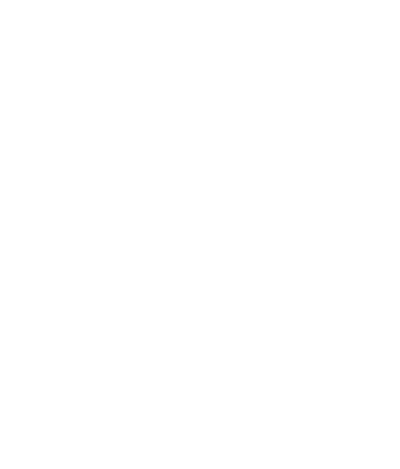Gli ecoreati reali superano i numeri: i grossi illeciti non si vedono, favoriti pure dalle leggi

Per fortuna abbiamo Legambiente che, ogni anno, ci ragguaglia sull’andamento dei reati ambientali, ricordandoci che nel 2023 sono aumentati del 15,6 % specie nel Mezzogiorno. Così come sono aumentati sequestri ed arresti. Cè da dire, però, che si tratta di numeri certamente inferiori al reale in quanto sono, ovviamente, relazionati ai controlli sul territorio, sicuramente inadeguati. Ed è quindi logico che […]
Rifiuti, Legambiente: 30 milioni persi dal Comune di Palermo

«Oltre 5 mesi per preparare e presentare progetti già in parte definiti da tempo dagli uffici della Rap e ritrovarsi nell’ultimo giorno della scadenza dell’avviso (tra l’altro prorogato di altri 30 giorni) di fronte a un problema tecnico insuperabile. Non è solo sciatteria, è incompetenza e dolo, l’ennesima beffa ai danni della città e dei […]
Sicilia Munnizza Free. Quattro milioni di cittadini senza raccolta differenziata efficiente sull’isola

Si è celebrata nei giorni scorsi la terza edizione di Sicilia Munnizza Free, organizzata da Legambiente in tutto il territorio regionale per migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti e la qualità dell’economia circolare sull’isola. Alla presentazione hanno partecipato, oltre all’assessore regionale all’Energia, Daniela Baglieri, al suo primo intervento pubblico, Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente; Luca […]
Clean Sea Life, in 4 anni rimosse 112 ton di rifiuti marini

In quattro anni di attività e monitoraggio sono state rimosse 112 tonnellate di spazzatura dai nostri mari, tra plastiche, mozziconi, reti e nasse. Oltre 170.000 cittadini tra subacquei, diportisti, pescatori e studenti, sono stati protagonisti insieme alle istituzioni della più grande campagna di pulizia di coste e fondali mai avvenuta in Italia, capace inoltre di […]
Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti: occasione per un’accelerazione virtuosa o l’ennesimo errore tecnocratico?

La nota congiunta di Legambiente, Greenpeace, WWF, Zero Waste Italy, Kyoto Club In merito alla recente adozione del Dlgs 116, recepimento della nuova Direttiva Quadro (Direttiva 2018/851) e della nuova Direttiva Imballaggi (Direttiva 2018/852) incluse nel Pacchetto UE sulla Economia Circolare, alla cui “visione” ambiziosa le strategie nazionali dovranno da ora in poi essere allineate, […]
Crescono i ‘Comuni Rifiuti Free’ 2020, ecco i numeri del dossier Legambiente

Sono 598 i Comuni Rifiuti Free,quelli dove ogni cittadino produce al massimo 75 chili di secco residuo all’anno: 51 in più dello scorso anno. E questa è davvero una buona notizia, specialmente se si considera che la crescita maggiore è avvenuta nel Meridione. I comuni rifiuti free del Sud Italia sono passati, infatti, da 84 a 122 e pesano, ora, per il 20,4% […]
Rinviata al 2021 l’entrata in vigore di sugar e plastic tax

“Sapevamo che il Paese era in attesa ma è stato un lavoro con un tempo necessario. La parola passerà al Parlamento. Penso e spero che questo lavoro potrà essere migliorato. È la manovra per fronteggiare questa fase di emergenza”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza dopo l’approvazione del dl Rilancio. “Ci […]
Assocarta e Legambiente: “Riciclo e raccolta differenziata della carta attività essenziali”

Assocarta e Legambiente sono usciti sui quotidiani nazionali del 23 aprile con una dichiarazione congiunta per chiedere al Governo che la raccolta differenziata e riciclo della carta vengano riconosciute come attività essenziali e strategiche per l’Italia. “Chiediamo al Governo e alle Autorità che le raccolte differenziate della carta vengano considerate essenziali nella gestione dei rifiuti, […]
Fiumicino è Comune Riciclone

È stato presentato lo scorso 17 dicembre, durante il Terzo Ecoforum di Legambiente Lazio che si è tenuto a Roma nelle sale dell’Hotel Quirinale e con il contributo della Regione Lazio, l’annuale dossier “Comuni Ricicloni e Ciclo dei Rifiuti nel Lazio”. Dossier che l’associazione ambientalista pubblica per analizzare lo stato di avanzamento delle buone pratiche dell’economia circolare, la quantità […]
Ecco le Economie Circolari di Comunità, un progetto di Legambiente e Ministero del Lavoro per diffondere l’economia circolare

Il progetto ECCO (Economie Circolari di COmunità), coordinato da Legambiente e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, punta a «Diminuire la produzione di rifiuti e incentivare i cittadini ad adottare stili di vita sostenibili, formare i giovani verso i green jobs e stimolare l’imprenditoria giovanile nel settore dell’economia circolare. Il tutto dando alle attività […]