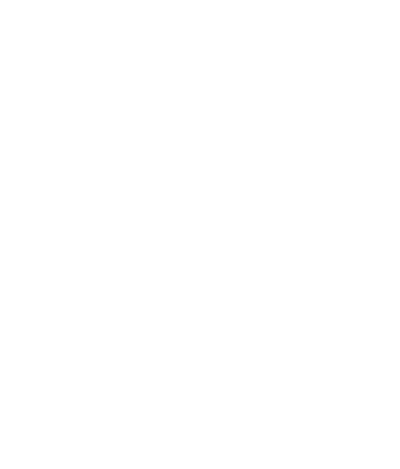115 milioni dal MASE a 75 progetti per riciclare la plastica

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica finanzierà 75 nuovi progetti per la creazione di impianti di riciclo dei rifiuti plastici, compresi quelli recuperati nelle acque italiane, con finanziamenti per 115 milioni di euro. Il dipartimento di sviluppo sostenibile del Ministero ha approvato il decreto di concessione dei contributi a progetti ritenuti particolarmente meritevoli nell’ambito […]
Presentazione docufilm “Oltre i luoghi Comuni”

Occorre andare oltre la narrazione non sempre veritiera sulla gestione dei rifiuti, indispensabile risorsa per l’economia circolare “Oltre i luoghi comuni” è il titolo del film-documentario che il regista Alessandro Scillitani ha realizzato, su proposta dell’associazione Greenaccord Onlus e con la partnership di E.S.P.E.R. Società Benefit e l’Editrice Italia libera, per “contribuire a far scoprire […]
L’UE boccia (di nuovo) l’Italia su rifiuti e smog
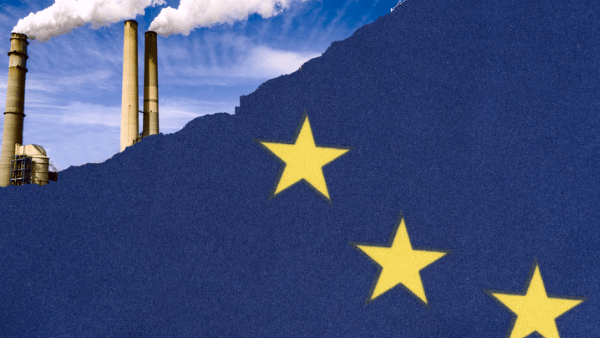
Presentata la valutazione dell’attuazione ambientale (EIR), il documento che valuta come l’Italia applica le norme UE: la Commissione ci boccia su rifiuti e smog, mentre ritiene incoraggianti i passi avanti del nostro Paese per l’economia circolare Norme ambientali europee, dove stiamo sbagliando?Nel documento di valutazione dell’attuazione delle norme ambientali europee il nostro Paese non presenta […]
A Roma il primo convegno nazionale dedicato ai Sistemi di Deposito Cauzionale

Si svolgerà a Roma nella mattinata del 7 giugno (dalle 10:15 presso la Sala Capranichetta, in Piazza di Montecitorio 125) il primo convegno nazionale dedicato ai Sistemi di Deposito Cauzionale aperto ai media e a tutti i portatori di interesse dal titolo: Il Sistema di Deposito Cauzionale: Allineare l’Italia alle esperienze europee per massimizzare la […]
Dalla raccolta dei CD e DVD nella bassa reggiana nasce un nuovo impianto di recupero

A quanti di noi non è mai capitato di avere un CD o un DVD per le mani? Sono tra gli oggetti che più sono stati usati nelle nostre vite quotidiane nei precedenti decenni. Per necessità lavorative, come memoria esterna grazie ai masterizzatori o come sostituti dei vinili e delle cassette audio e video, hanno finito […]
Trento vieta la plastica nel pubblico, Sanpellegrino e Mineracqua ricorrono al Tar

A Trento è scoppiata la guerra della plastica. A scatenarla la decisione della Provincia autonoma di bandire, a partire dal prossimo luglio, la plastica monouso per tutti gli eventi organizzati, finanziati o patrocinati dalla Provincia e dagli enti collegati per ottenere il marchio “Ecoristorazione Trentino” e dal gennaio 2023, da tutti i servizi di somministrazione e vendita – […]
Raccolta dell’organico obbligatoria. Ecco cosa cambia per i Comuni

Dal primo gennaio 2022 è scattato l’obbligo della raccolta differenziata dell’organico per tutti i Comuni d’Italia. Ma a che punto siamo sul territorio nazionale? Tra l’aumento di prodotti compostabili, uno sguardo a norme e buone pratiche che potrebbero fare la differenza In Italia la raccolta differenziata dell’organico è a buon punto. L’organico rappresenta il 43% […]
Il PET è la plastica più riciclabile e riciclata, ma potrebbe essere più circolare

Quanto è effettivamente circolare il PET? Quante bottiglie vengono effettivamente raccolte per il riciclaggio? Quanto PET viene effettivamente riciclato? E quanto di quello riciclato viene utilizzato nella produzione di nuove bottiglie? Un rapporto pubblicato oggi da Zero Waste Europe e da Eunomia Research & Consulting getta nuova luce sulla riciclabilità di questo diffusissimo polimero Un […]
Anci-CONAI, aumentati i corrispettivi per la raccolta
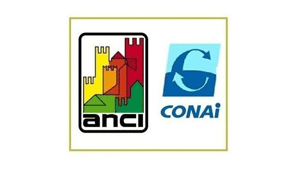
La decisione del comitato di verifica congiunto dice che il coefficiente di revisione dei corrispettivi è il 2,27% Il Comitato di Verifica ANCI-CONAI ha formalizzato la revisione annuale dei corrispettivi riconosciuti per la raccolta e il conferimento ai Consorzi di filiera dei rifiuti di imballaggio. In particolare, i corrispettivi hanno avuto un incremento che tiene conto dell’indice NIC 2020/2019, che […]
La Commissione Ue contro il recepimento della direttiva Sup. Ora l’Italia è rischio infrazione

Per l’Italia continuano i problemi in merito al recepimento della direttiva UE che mira a ridurre la dispersione della plastica monouso nell’ambiente. Dopo la richiesta inascoltata di una sospensione del provvedimento legislativo, il rischio di una procedura d’infrazione si fa più concreto Pronti… via? Anzi no, meglio un rinvio. Da oggi è in vigore il […]